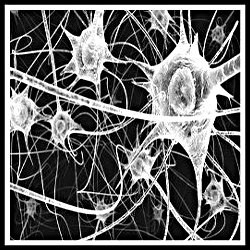Se ne sta andando. Credono che un li senta, che un li veda, scrollano il capo come a fanne cade’ i pensieri: ma quelli e non cadono, là stanno e là restano. I loro, e i miei.
Perché ne ho di pensieri, anche se credono di no. Via, io li capisco che un ci credono, perché i pensieri non si vedono, diamine. I pensieri… ne ho e non ne ho. Che poi un è facile capi’ e che sono, i pensieri, e a dilli meno ancora. Per esempio, loro mi dicono:
“ascolta la radio”
e io penso che a me un m’importa, la radio, che parla di gente che un conosco, di cose che un conosco, e la musica o è fastidiosa o è bella ma quella bella e ne ho sentita tanta che un me n’importa più di sentilla alla radio, la sento nella mi’ testa quand’è silenzio e c’è tanto silenzio a volte che mi mette ─ paura? No, paura no, e tristezza nemmeno. Silenzio, mi mette, il silenzio mette silenzio, ecco, e a volte mi va bene e a volte un mi va punto bene e allora chiamo.
I primi nomi che mi passano in capo: Anna, Maria, chiamo, anche se un so chi sono. Ma è i primi nomi che mi vengono, e nemmeno io so perché. Sarà che sono nomi semplici, un lo so davvero. E allora. Mi chiedono se chiamo Maria perché era il nome della mi’ mamma, ma io la mi’ mamma e la chiamavo mamma, o che discorsi. Allora loro s’intristiscono:
“Un c’è più con la testa”
fanno, perché dovrei chiamare la mi’ nora per nome, Fiamma, e lo so che si chiama Fiamma, o il mi’ figliolo che si chiama Alfredo, ma se li chiamo vengono e vogliono sape’ e che c’è e che voglio, e io un è che voglio qualcosa o sì ma non sono sicura e di che cosa, voglio un gelato? Ma sì, un gelato e ci sta sempre bene, e lei mi porta il gelato e qualche volta ne prende uno anche per sé ─ fa bene, diamine ─ e lo mangiamo insieme, con lei o col mi’ figliolo, più spesso col mi’ figliolo che a lui il gelato piace sempre, così passa mezz’ora e alla fine siamo punto e daccapo: loro sono contenti che son stata contenta e del gelato, ma chi sono Anna o Maria un lo so io e un lo sanno loro, e allora. E quando s’allontanano a rigoverna’ piattini e cucchiaini, che io ci voglio il piattino e il tovagliolo, li sento di là che borbottano:
“Mamma sta andando, non c’è più con la testa”
e allora vorrei dirgli che no, ci sono, con la testa almeno che il corpo quello e un mi risponde a modo, solo che non so bene e che voglio e che un voglio e che succede dentro, alla mi’ testa.
Che se ci guardo dentro vedo tanto disordine, a modino un c’è niente ma piena però è piena, di pensieri che un si vedono e che bisognerebbe dilli: perché i pensieri si vedono colle parole, questo lo so, ma se le parole un mi vengono più e che ci posso fare? Se dico:
“ho caldo”,
per esempio, loro:
“ah ci credo, fa un caldo che strugge, t’apriamo la finestra?”,
rispondono, e io:
“no, chiudete tutto”
e loro:
“no, via, che viene un po’ d’aria, s’apre”.
E aprono e fan bene, che l’aria viene e va e si sta un poìno meglio, è vero: ma io un volevo di’ “ho caldo” per dire che ho caldo, anche se ho caldo, ma che a tenere chiuso viene caldo anche se io voglio tenere tutto chiuso, e questo un glielo so spiegare: è che con l’aria entra in casa tante altre cose, i rumori del barre che un mi piacciono, voci di gente che un so chi è ma grida, e i motorini, e i pùrman che vanno in piazza Grande uno e ad Antignano l’altro e l’ambulanze giù nella via grande che penso sempre che vengono per me… Allora penso che glielo dico, magari son contenti che dico una cosa che ho pensato per fargli vedere che so dire i pensieri che mi vengono:
“oh l’ambulanza, è che viene per me?’
E loro:
“Ada, ma che dici, non hai nemmeno un po’ di febbre, non vorrai l’ambulanza”.
E infatti non ho detto che la voglio, ho solo chiesto se è per me, e invece di essere contenti che ho detto una cosa che pensavo, che gli ho fatto vede’ che penso ancora, ovvia, son bell’e preoccupati. Un li capisco, un li capisco più.
Alla fine è tutto qui: io un li capisco e loro un capiscono me. Come co’ gli ordini, che si lamentano che un chiedo niente col per piacere ma solo “dammi” e “fammi” e “portami” e “toglimi”, o e che dovrei dire? Io sono in casa mia, sarò padrona, dico.
“No, Ada, qui un ce n’è di padroni, qui si fa tutto per te ma padroni un ce n’è e servi nemmeno”.
Servi! E chi l’ha mai avuti servi, le ragazze che cucivano per me quando facevo la sarta sì ma servi, mai. Noi un s’era nati d’ave’ servi, a servire piuttosto e anco quello, mai. Ve l’immaginate quando lavoravo a chiedere ogni volta alle mi’ ragazze:
“Per piacere, che me lo passi un ago piccino?”
o
“Me l’infili il filoforte per piacere, che ho da fermare l’orlo?”.
Si diceva “dammi” e “infilami”, senza tante moine.
Loro invece, il mi’ figliolo dico e la su’ moglie e anche la signora che dorme di là, e voglion le moine. Ma a me e un mi riesce. Mi chiedono se mi piace d’esse comandata: diamine, e un mi piace no.
“Allora perché vuoi comandare noi?”,
chiedono. E un lo so, mi pare che va bene così, e poi un m’importa. Io chiamo e chiedo questo e quello via via che mi viene, se me lo danno bene e se no si farà senza. Però li vedo che son tristi, gli vedo gli occhi tristi, e allora ogni tanto lo dico, “per piacere”, e son contenti. Ma poi la volta dopo mi dimentico, o e che devo fare.
E loro ricominciano che sto andando, che me ne sto andando, che chi lo sa se un me ne sto di già in un mondo tutto mio. Mah. A me sbaglierò ma mi pare che son sempre qua e che il mondo è uno solo.
Forse dovrei dire questo, a vedere se son contenti. Magari lo dico, domani.